Giravolte e ragazzi di vita III – E ancora metafore


Illustrazione di Nathalie Lees
Il COVID 19 o la perfetta metafora di chiusura di un’epoca
“Fatta l’Italia, ma ora bisogna fare gli italiani”
Massimo d’Azeglio, 1861.
Non essendo guerra ma catastrofe, servono i cittadini non i soldati, in Italia e altrove.
La catastrofe può essere un’opportunità per “fabbricarli”.
Conte, Macron, Sánchez, Johnson e persino “il comico incosciente di noialtri”, al secolo Sebastian Piñera, hanno “dichiarato guerra” al virus e straparlano continuamente di una “situazione di guerra” che evoca “trincee” e “scontri epici” che, per fortuna loro, non hanno mai visto (Piñera le ha viste, ma da lontano).
Per combattere questa “guerra irregolare” è stata arruolata tutta la popolazione chiamata a praticare valori militari come, ad esempio, l’accettazione indiscussa di ogni decisione.
Che non si tratti di una guerra bensì di una catastrofe non significa alleggerire le misure.
Anche una catastrofe rende indispensabile mobilitare tutte le risorse disponibili per proteggere la società civile, ivi inclusi gli equipaggiamenti e l’esperienza delle forze armate quando necessario, ma le misure eccezionali non autorizzano l’uso leggero di una metafora che trasforma la sensibilità della popolazione formattandone la modalità di ricezione dei messaggi.
Se non si vuole fare solo della poesia, le politiche devono includere la cura, l’accoglienza, la condivisione e la protezione, senza le quali non esiste neppure una politica sanitaria adeguata.
Il virus ha il merito di averci messo di fronte la realtà, di averci portato fuori dal mondo di fantasia in cui si viveva da anni. Non bisogna deformare questa percezione del reale assumendo deviazioni tipiche della peggiore eredità della tradizione occidentale.
Ad eccezione dell’ambito strettamente sanitario, la metafora della guerra è una pessima cornice.
Guerra contro chi?
Chi è il nemico?
Gli atteggiamenti dei nicaraguensi e degli statunitensi citati nel capitolo precedente erano un riflesso condizionato richiamato dalla parola “guerra”, che tratteggia automaticamente un umano negativo disumanizzato e criminalizzato, quindi da eliminare e, dialetticamente, umanizzando il virus al quale viene concessa personalità, volontà, attività e intenzionalità.
Poiché il nemico di questa sfida si trova, almeno potenzialmente, dentro ognuno di noi, è del tutto esclusa la possibilità di trasformarlo in untore, oggetto di persecuzione o di aggressione bellica.
Viceversa, volente o nolente la scivolosa idea di “guerra” offre a coloro che, spinti da una paura medioevale, trasformano le vittime in nemici portatori del virus dimenticando, tra altre piccole cose, che loro stessi lo sono, almeno potenzialmente.
Intendo dire che la guerra si può fare solo tra umani. Se bisognerà farla al virus, finiremo facendola contro i corpi che lo portano o contro la stessa umanità che, teoricamente, vorremmo proteggere.
Nello stato di “catastrofe” è necessario “reprimere” severamente chi viola il confinamento mettendo in pericolo sé stesso e gli altri, i suoi vicini ed il sistema sanitario in generale, ma nemmeno questi sono i “nemici” di uno “scontro bellico, salvo confondere – volutamente – il virus con i suoi potenziali portatori generando una “guerra civile” tra i portatori potenziali.
L’umanità è fatta da esseri vulnerabili e fragili. La nostra storia è stata ed è attraversata dalla malattia e dall’esposizione alla fame, ai virus e all’abbandono.
Siamo sopravvissuti costruendo rapporti con la natura e tra le persone per minimizzare il rischio e l’insicurezza.
La cura e la precauzione, il mutuo appoggio, la cooperazione, la sanità e l’educazione pubblica, la resistenza e la condivisione delle ricchezze hanno permesso di mettere in moto società – spesso brutalmente disuguali e ingiuste – per cercare di superare questo piccolo inconveniente: la vita segue il suo corso in corpi fragili, vulnerabili e incapaci di vivere in solitudine.
Un virus non è un nemico cosciente e malvagio bensì un rischio inerente alla vita e ciò che davvero dovrebbe spaventarci è pensare di edificare società ignare dal fatto che esistono i virus, la malattia, il cattivo raccolto e la tempesta.
Costruire economie e politiche basate sulle fantasie di esseri pensati come se fossero sprovvisti di corpo e di legami con la terra, genera una guerra contro la vita, contro i cicli, contro i limiti, contro i vincoli ed i rapporti.
Il neoliberismo, col beneplacito tacito o espresso di molti, ha nascosto, diminuito e disprezzato i compiti, i mestieri ed i tempi dediti alla cura che diventano immediatamente visibili con le catastrofi e le guerre.
Oggi, ad esempio, che la sanità debba essere pubblica e, aggiungo, gratuita, è diventata sentimento predominante. Ma tutti sappiamo che non era così fino a pochi mesi fa. Che in Italia non lo è stata per almeno un ventennio, dal governo dello “psiconano” fino a tutto il 2019. Che, ad essere precisi, non è stato un sentimento predominante fin dall’invenzione della “Sindrome TINA” (“There is not alternative”), col quale la signora Thatcher trasformò in dogma la politica inaugurata dalle dittature latinoamericane negli Anni ’70. Ovvero, non è stato un sentimento dominante per quasi mezzo secolo.
La guerra e la violenza armata, espressioni di machismo recalcitrante e giustificazioni per il sacrificio di vite umane in nome di una “causa superiore”, sono la negazione della cura. Quando la “causa superiore” è proprio la salvezza delle vite umane in pericolo, nessuno dovrebbe essere talmente stupido da pensare che valga la pena di “offrire virilmente la propria vita per la causa”, quando la causa è proprio il mantenimento della propria vita.
Quindi, non ci sarà alcuna vittoria finale che dipenda dalla disciplina e dalla conversione della popolazione in una disciplinata soldatesca. Anzi, il sacrificio richiesto nella catastrofe, come nella retrovia di qualsiasi guerra, è proprio il contrario: intensificare la logica della cura, della precauzione, del sostegno quotidiano e intenzionale della vita in tempi di catastrofe.
Non è complicato: sono gli sforzi necessari a sostenere la vita quotidianamente, anche in tempi di non virus.
Simone Weil ci ha spiegato che in ogni guerra l’umanità si divide tra coloro che hanno le armi e coloro che non le hanno e che i secondi, indipendentemente dal bando o dalla bandiera, sono sempre senza protezione (“Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale”, 1934).
Nel nostro attuale stato di catastrofe, tutti siamo potenzialmente vittime del virus ma non tutti possiamo praticare il confinamento.
Coloro maggiormente esposti – personale medico, trasportatori, personale dei supermercati, badanti e colf, incaricati dei lavori di pulizia ecc. – non dispongono di armi né combattono tra loro per proteggere i “loro”.
Al contrario delle guerre, questo esercito disarmato, munito solo di microscopi, termometri, strofinacci, mani e senso del dovere, non fa la guerra, né tra di loro né con quelli che sono rinchiusi nelle loro case, comunque meno esposti ma altrettanto disarmati.
Si espongono per proteggere tutti, ben sapendo che così proteggono anche loro stessi e difendono l’ordine civile da cui dipendono e che da loro dipende.
Perciò è una irresponsabilità immorale e suicida non rispettare la normativa sanitaria. Ma la situazione che stiamo attraversando è quanto di più distante della guerra e della sua “etica” che, bisogna ricordarlo, si scaglia contemporaneamente contro ogni identità e contro ogni universalismo.
Tuttavia, qualcosa agisce contro la “causa superiore”, la salvezza di tutte le vite in pericolo. Non è il virus, ma sono le decisioni economiche degli ultimi decenni e le politiche da correggere immediatamente per proteggere i socialmente vulnerabili.
Ovvero, ci sono coloro che sono maggiormente responsabili: sono i nostri politici ed i nostri gruppi dirigenti economici. Quindi, in ultima istanza siamo noi, perché li abbiamo eletti e permesso di agire in piena impunità e senza alcun ritegno. Ossia perché ognuno ha la classe dirigente (ed i giornalisti) che si merita.

Reuters
La guerra è stata e resta quotidiana normalità in molte aree del mondo, ma due generazioni europee non l’hanno conosciuta.
E’ comprensibile che per il loro vissuto, questo bagno di realtà sia la cosa più somigliante ad un conflitto bellico.
Viceversa, è in sostanza il contrario di una guerra, poiché la realtà non ci si presenta davanti come cattiva volontà o identità bellicosa, ma come avversa contingenza impersonale in un contesto capitalistico che, da molti anni, fa la guerra alla natura, ai corpi e alle cose.
Quindi, ciò che bisogna ribaltare e trasformare è la teorica impersonalità non bellica della catastrofe capitalistica.
Perciò è così importante e utile la tragica convergenza tra le responsabilità individuali e istituzionali che ci ha dimostrato l’importanza delle cure personali e collettive.
Forse la fine del capitalismo sarà accompagnata da guerre, ma non sarà una guerra bensì un processo.
Non è l’occasione per parlarne ma penso che questo “virus” replicante probabilmente rappresenti l’anticipo e la metafora della sua dinamica interna caratterizzata dalla incivile mancanza di limitazione, dalla sua hybris, come avrebbero detto i vecchi greci.
Come dimostra la storia recente, continuerà ad apparire e lo farà sempre come “catastrofe”.
L’immagine dell’esercito sceso per strada, dovunque sia, può essere giustificata ma è sempre inquietante.
Perché non lo sia, è indispensabile che gli interventi non s’iscrivano in una logica di “guerra”.
Solo i medici possono parlare di guerra e le madri sono le più indicate per meglio dirci cosa sia la disponibilità al sacrificio.
Affrontare una “catastrofe” è già sufficientemente duro per non sentire assolutamente il bisogno di avere paura delle nostre co-vittime o di coloro che tentano di proteggerci.
Gli esempi di malvagità arendtiana, “banali” quanto truffare vecchiette e rubare il pane agli affamati, sono diffusi, ma non sono novità.
Lo è, invece, che il virus abbia diffuso un’epica casalinga che consiste, ad esempio, nella scoperta che il nostro odioso vicino di casa, che sta a quattro metri di distanza chissà da quando, ci è simile e, anzi, è quasi un amico al quale purtroppo non possiamo per ora abbracciare.
Ed è paradigmatico che, proprio quando abbracci e baci sono vietati, conosciamo i nomi di coloro che vivono nel nostro condominio e ci preoccupi che abbiano o meno cibo o medicine.
Non essendo una guerra ma una catastrofe, la vinceremo solo riducendo le vittime.
Forse vinceremo, ma bisognerà prepararsi sia per la prossima catastrofe, sia per il terremoto che seguirà questa catastrofe.
Perché abbia una ripercussione cruciale e positiva, dovremo riordinare le priorità, le nostre e le generali.
Penso che riordinare le priorità significhi farsi carico dei problemi essenziali: la povertà diffusa, la precarietà esistenziale, la vita degli altri umani, lontani nello spazio ma a noi contemporanei.
Perciò chiudo questa puntata con tre citazioni non metaforiche.
Sulla povertà, scrive il britannico Paul Slack (“The English Poor Law 1531-1782”, 1995):
“Il 20% della popolazione è al limite della sopravvivenza e il 5% deve essere soccorsa localmente.
Poi ci sono i «vagabondi». Alcuni sono dei disadattati sociali che cadono persino nel brigantaggio, ma per la maggior parte sono lavoratori precari. Tra di loro, molti sono giovani tra 15 e 25 anni, circa un quarto sono ragazze che cercano di trovarsi una qualsiasi forma di sbarcare il lunario.
La principale causa della povertà è la sottoccupazione (…). La legge distingue tre gruppi d’indigenti: poveri inadatti ma meritevoli (anziani, bambini, invalidi), disoccupati involontari e poveri indegni (mendicanti e vagabondi).
Ai primi bisogna fornire cibo, vestiti e un po’ di denaro. Ai secondi un lavoro o qualche corso di riqualificazione. I poveri indegni sono criminali da fustigare e vanno cacciati”.
Allargando lo sguardo e usando come riferimento il mondo, i dati non sono cambiati in meglio.
Sulla precarietà, leggo dal “Corriere fiorentino” (“Kirby aspiratutto. Con truffa e frustate”, 14 maggio 2010):
“Secondo la guardia di finanza, alla «Italcarone» di Incisa Valdarno reclutavano personale con inserzioni sui giornali, senza specificare quale mansione avrebbero dovuto ricoprire, poi venivano addestrati e trasformati in telefonisti o venditori: ogni mattina, all’inizio della giornata lavorativa, venivano «caricati» da quelli che «ce l’avevano fatta» con l inno nazionale, canti e slogan e incitati a raggiungere risultati inarrivabili, che sarebbero stati ripagati con viaggi in località esotiche. E prima del raggiungimento dell’obiettivo ricevevano insignificanti gadget o attestati di lode firmati dall’azienda, ma anche frustate sulle gambe quando gli appuntamenti non erano ritenuti sufficienti o umilianti richiami davanti agli altri”.
Temo che alla fine della catastrofe in corso, sia gli aspiranti ad essere reclutati che i Kirby aspiratutto, si moltiplicheranno. Per fermarli sarà necessario costruire alternative.
Sulla vita degli altri, nel “Informe sobre la esclavitud en Bolivia 2008”, la Commissione Interamericana sui Diritti Umani (CIDH) scrive:
“In Bolivia abbiamo verificato la continuità di condizioni di servitù per debito del tutto analoga alla schiavitù e al lavoro forzato (…). Gli indigeni del Chaco vivono in estrema povertà, sottomessi a punizioni tra cui frustate, incendi delle loro coltivazioni ed eliminazione dei loro animali”.
Ricordo che, poco dopo, in Bolivia arrivarono al governo il MAS ed Evo Morales.
Volevano, e iniziarono a farlo, fare realtà lo slogan comparso anni dopo nelle piazze cilene: “Trasformare la dignità in abitudine”.
Nel 2019 militari e fascisti hanno interrotto, spero momentaneamente, questa esperienza. Ma questa è un’altra storia.
R. A. Rivas
Città di Castello, aprile 2020

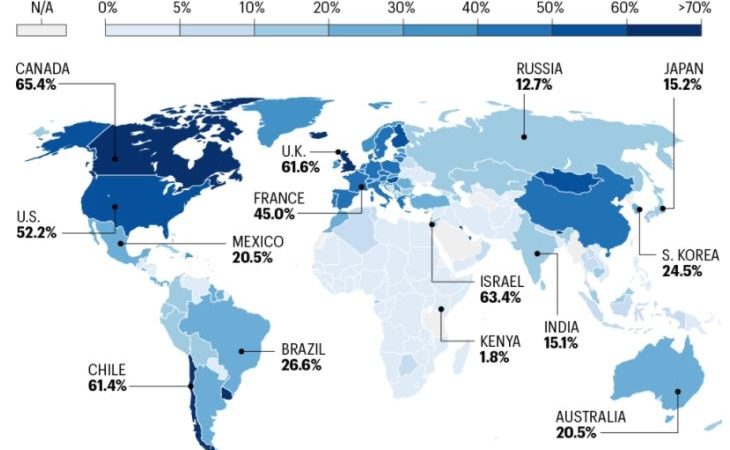



Molto interessante il tuo pezzo Andrea, lo comparto. Grazie per questa analisi originale e profonda che ci invita ad una riflessione nei tempi del coronavirus…
Tremendo analisis de la situacion actual, de como la continua transformacion de todo en objeto de mercado ha llevado a la humanidad a ser cada vez menos humana, deberemos seguir luchando entonces por nuestras causas perdidas
Stupendo, Rodrigo, kompliments dal tuo amico marco coccino. Ti allego, a conferma, l’analisi linguistica di Annamaria Testa. Ciao! (Alamy)
CORONAVIRUS
Smettiamo di dire che è una guerra
Annamaria Testa, esperta di comunicazione
30 marzo 2020
FacebookTwitterEmailPrint
Specie in tempi difficili, dovremmo sforzarci di usare parole esatte e di chiamare le cose con il loro nome.
Le parole che scegliamo per nominare e descrivere i fenomeni possono aiutarci a capirli meglio. E quindi a governarli meglio. Quando però scegliamo parole imprecise o distorte, la comprensione rischia di essere fuorviata. E sono fuorviati i sentimenti, le decisioni e le azioni che ne conseguono.
Tra l’altro: sulla scelta delle parole che servono per descrivere le cose si gioca anche buona parte della propaganda politica contemporanea.
Per esempio, quando sceglie di chiamare “virus cinese” il Covid-19, Donald Trump non si limita a proporre un diverso nome per nominare la medesima cosa. Fa, per dirla con George Lakoff, una esplicita operazione di framing, di incorniciatura. Inquadra, cioè, il virus evidenziandone la provenienza, e quindi attribuendone la responsabilità. Del resto, ce lo ricorda il Guardian, Trump è piuttosto abituato a compiere operazioni di framing, e lo fa con (ehm…) un discreto successo.
Operazioni di incorniciatura
Ma non sono Donald Trump e il suo uso fallace del linguaggio il punto di questo articolo. Teniamoceli, a mente, però, come esempio di applicazione di un frame: una cornice che può cambiare radicalmente il senso di qualcosa, attribuendole una specifica qualità, o isolando ed esaltando una singola qualità fra molte.
Per descrivere e comprendere la realtà noi la semplifichiamo compiendo, non necessariamente in malafede, una quantità di operazioni di incorniciatura.
Lo facciamo ogni volta che definiamo un fenomeno alla luce di quella che ci sembra la sua caratteristica emergente.
Lo facciamo (in modo efficacissimo, e determinante in termini di comprensione e interpretazione) quando usiamo una metafora: una formula linguistica che condensa in pochissime parole un intero racconto, e che evoca immagini intense, cariche di pathos.
Dunque, una metafora può essere una cornice folgorante (anche questa è una metafora) e altamente memorabile.
Eccoci al punto. In un eccellente articolo uscito su Internazionale pochi giorni fa, Daniele Cassandro segnala che “l’emergenza Covid-19 è quasi ovunque trattata con un linguaggio bellico: si parla di trincea negli ospedali, di fronte del virus, di economia di guerra”.
Cassandro segnala, citando Susan Sontang, che però “trattare una malattia come fosse una guerra ci rende ubbidienti, docili e, in prospettiva, vittime designate”. E conclude affermando che la metafora del paese in guerra è rischiosa nell’emergenza che stiamo vivendo perché “parlare di guerra, d’invasione e di eroismo, con un lessico bellico ancora ottocentesco, ci allontana dall’idea di unità e condivisione di obiettivi che ci permetterà di uscirne”.
L’automatismo della metafora bellica mi sembra troppo persistente e diffuso per essere ridotto a pura sciatteria lessicale
Lo psichiatra Luigi Cancrini ribadisce concetti analoghi in un’intervista a Repubblica: “La guerra è il tempo dell’odio. In guerra per sopravvivere si è costretti a uccidere l’altro”, dice. “Invece questo di oggi è il tempo della vicinanza e della solidarietà”.
E il sociologo Fabrizio Battistelli, su Micromega, dopo aver meticolosamente elencato una quantità di metafore belliche usate sia da politici sia da esperti, sottolinea che “è sbagliato mettere sullo stesso piano due fenomeni – l’epidemia e la guerra – la cui essenza è diversa. Ciò emerge nelle due distinte azioni del contrasto e della prevenzione. Mentre nel contrasto epidemia e guerra hanno vari punti di contatto (giustamente l’ideatore del ventilatore multiplo ha parlato di ‘medicina di guerra’) l’azione di prevenzione è diversa e per molti versi opposta”.
L’automatismo che porta a impiegare metafore belliche a proposito del Covid-19 mi sembra particolarmente insidioso anche perché, in realtà, i termini “malattia”, “epidemia”, “infezione”, “virus”, “contagio” sono essi stessi impiegati come metafore potenti. Basti pensare all’uso esagerato del termine “virale” che in questi anni si è fatto a proposito di internet e dei social network. A quante volte si è parlato di “infezione mafiosa”. O di “epidemia di solitudine”.
E allora, perché diavolo sentiamo il bisogno di mascherare con una metafora una realtà che ha attributi così forti e drammatici da essere essi stessi usati come metafore? Perché mai sentiamo il bisogno di alterare una narrazione potente e inequivocabile incorniciandola con un’altra narrazione?
Non è una guerra ed è pericoloso pensare che lo sia perché in questa cornice risultano legittimate derive autoritarie
L’automatismo della metafora bellica mi sembra troppo persistente e diffuso per essere ridotto a pura sciatteria lessicale.
Può darsi che derivi dal fatto che l’immaginario della guerra è profondamente radicato nell’inconscio collettivo. O può darsi che derivi dal fatto che oggi (di nuovo Battistelli) “le politiche strategico-militari concretizzano la dicotomia amico/nemico, teorizzata dal pensiero conservatore ma di fatto condivisa da tutti, come la quintessenza del ‘politico’”.
Conseguenza: si ragiona e si investe molto più secondo logiche nazionalistiche e di conflitto che secondo logiche universalistiche e per prevenire rischi globali.
Può darsi, insomma, che alla base di tutto ciò ci sia una logica ottusa e inadeguata, che sa leggere l’intera realtà solo in termini dicotomici e muscolari, e non è proprio capace né di ragionare, né di immaginare o progettare in termini di inclusione e di cura. Non ci riesce nemmeno adesso, quando inclusione, condivisione e cura sono l’unico imperativo possibile.
Di fatto, scrive Matteo Pascoletti su Valigia Blu, “il gergo militaresco e l’insistente visione bellica non aiutano ad affrontare l’emergenza da un punto di vista psicologico e cognitivo, e se non ci aiutano come individui di certo non ci aiutano come società”.
Pandemia. Pericolo globale. Tragedia collettiva. Difficile emergenza (come dice il presidente Mattarella). Tempesta che smaschera le nostre false sicurezze (come dice papa Bergoglio).
Ciò che riguarda il Covid-19 è tutto questo, ma non è una “guerra”.
L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LA PUBBLICITÀ
Questa non è una guerra perché non c’è, in senso proprio, un “nemico”. Il virus non ci odia. Non sa neanche che esistiamo. In realtà, non sa niente né di noi, né di sé. È un’entità biologica parassita.
Non è una guerra e dunque è tremendo e inaccettabile che per “combatterla” muoiano medici e infermieri: non sono “soldati” da mandare in “battaglia”, pronti a compiere un “sacrificio”. Usare il frame della guerra per implicare, insieme all’eroismo, l’ineluttabilità del “sacrificio” è disonesto e indegno.
Non è una guerra ed è pericoloso pensare che lo sia perché in questa cornice risultano legittimate derive autoritarie.
Non è una guerra perché le guerre si combattono con lo scopo di difendere e preservare il proprio stile di vita. L’emergenza ci chiede, invece, non solo di progettare cambiamenti sostanziali, ma di ridiscutere interamente la nostra gerarchia dei valori e il nostro modo di pensare. Prima cominciamo, meglio è.
Caro Andrea, come sempre un lucidissimo analisi e rinvigorante il tuo, credere e avere propettive.. Tutti abbiamo il dovere di assumerci la responsabilità dell’urgenza di questa realtà. Inevitabilmente ci resta la formula di sempre azioni piccole o grandi ma colettive. Grazie.