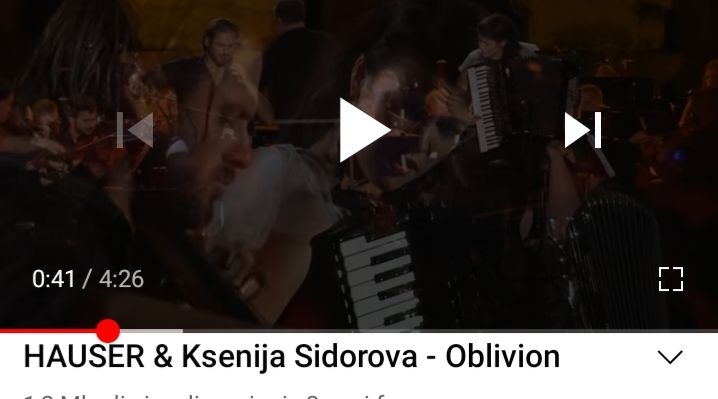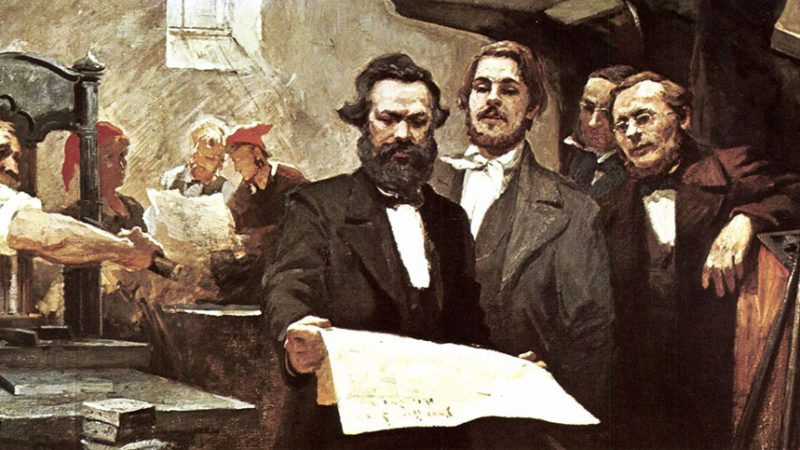Omaggio a una donna inglese

Quel pomeriggio del 4 giugno 1913, Emily Wilding Davison riusciva a camuffarsi tra la folla festante che assisteva alla 134a edizione del.”Epson Derby”, la più importante corsa di cavalli del Regno Unito.
Lavorando di notte, Emily si era laureata a Oxford in “Lingua e letteratura inglese” ma, formalmente, non si era mai laureata: ad Oxford non si consegnavano lauree alle donne.
Pochi giorni prima della sua irruzione all’ippodromo, Emily era uscita da uno dei suoi tanti periodi di carcere frutto della sua militanza nella Woman’s Social and Political Union (WSPU).

All’epoca, soggiornare in carcere era abituale per le donne inglesi, specie dopo che il bonario re (che i reali siano sempre buoni è un assioma) aveva proclamato la “Cat and Mouse Act”.
Il Gatto designato dalla legge era la polizia, il Topo le donne suffragette che, portate in carcere, erano alimentate forzatamente, rilasciate quando erano in pericolo di morte e ricondotte in galera non appena avevano ricoverato le forze e, ricalcitranti, minacciavano di riprendere la loro lotta.
Quel giorno, Emily scese in pista coperta con la bandiera viola, bianca e verde del movimento mentre transitavano i cavalli al galoppo.
Intendeva, probabilmente, prendere le briglie di Arner, il cavallo del re, per introdurvi la bandiera del movimento e fargliela portare lungo il miglio e passa della corsa..
Veniva invece investita dalla incolpevole bestia.
Scaraventata a diversi metri di distanza, i medici acertavano subito la frattura del cranio.
Il giorno dopo, Giorgio V esprimeva sul “Times” il proprio “disappunto per la giornata rovinata”.
Più ciarliera, la regina faceva pubblicare il testo del suo telegramma al fantino: “Guarisca presto dal triste incidente causato dal comportamento deplorevole di una donna lunatica e terribile”.
Emily moriva il 14 giugno 1913.
A Londra, 40mila donne partecipavano al suo funerale di bianco, viola e verde vestite.
Sui bordi delle strade migliaia di altre donne, vestite di nero, assistevano commosse.
Tutte avevano la frangia nera sulle sottane e sulle camice.
Le riprese dell’epoca mostrano anche alcuni uomini.
Herbert Jones, il fantino del re, che era rimasto leggermente ferito, faceva arrivare un telegramma di condoglianze e una corona.

Giorgio V e consorte erano troppo occupati in qualche battuta di caccia per poter dire qualcosa. Bisogna capirli: la vita dei sovrani è dura.
Il giorno dopo, 15 giugno 1913, il feretro veniva portato a Morpeth, la città natale di Emily, accompagnato da altre migliaia di donne.
L’epitaffio scolpito sulla sua tomba riproduceva il moto della WSPU: “Atti, non parole”.
Seguivano i terribili anni della macelleria denominata “Prima guerra mondiale” in cui le donne assumevano buona parte dei “lavori maschili”.
Agli inizi del 1918, bontà loro, reali e parlamento concedevano il diritto a voto “alle mogli dei capofamiglia che avessero superato i 30 anni”.
Ma la ripresa delle agitazioni femminili li costringevano ad estendere il diritto a voto a tutte le donne maggiorenni il 2 luglio 1918.
In altre lande più arretrate (e/o meno combattive sul lungo periodo), le donne avrebbero dovuto attendere ancora qualche decennio.
All’unanimità – strano ma vero – i giornalisti inglesi descrivevano Emily come “una squilibrata”. Era in uso, “allora”, per le donne che esigevano i loro diritti.
Il settimanale «The Suffragette» usciva invece con una copertina che la raffigurava come un angelo alato, corredata da una citazione del “Vangelo di Giovanni”: “Nessuno ha un amore più grande di chi sacrifica la propria vita per i suoi amici”.